 Sa femina accabadora era la dama nera della buona morte. Un’ambigua figura femminile miscelata tra folclore ed un misterioso mondo di rituali. Preghiere, cerimoniali spiritici, superstizioni e magie avvolgevano questa funerea figura impersonata in una donna.
Sa femina accabadora era la dama nera della buona morte. Un’ambigua figura femminile miscelata tra folclore ed un misterioso mondo di rituali. Preghiere, cerimoniali spiritici, superstizioni e magie avvolgevano questa funerea figura impersonata in una donna.
Solitamente era una tra le anziane del paese che, su richiesta delle famiglie, veniva chiamata in una casa sfortunata dove era presente un moribondo, un ferito grave oppure un anziano la cui qualità della vita era ormai compromessa da una malattia o da un morbo.
Ecco, il suo lavoro era praticare la buona morte, l’eutanasia.
A volte si trattava della stessa amorevole dama che, prima, aveva fatto il possibile per lenire i mali dello stesso sventurato, oppure aveva provato ad allontanare quegli spiriti maligni che lo tenevano posseduto tra le bianche lenzuola. E, così, quando i rituali magici, gli infusi, le pomate ed i miscugli di erbe divenivano insufficienti ecco che l’unico modo per mettere fine alle sofferenze, spesso atroci, era quello di richiamare in casa sa femina accabadora, ma questa volta con indosso un vestito di morte.
Accabadora o femina agabbadòra era una figura dell’epoca arcaica il cui nome deriva dal sardo s’acabbu che significa “la fine”, mentre il termine accabaddare evoca l’incrocio delle mani di un morto, oppure “mettere a cavallo”, ossia “far partire”. Ma il termine è legato anche alla lingua spagnola dove acabar, fa riferimento a “finire, terminare”.
Ovviamente si trattava di un cerimoniale pagano, osteggiato anche dalla Chiesa ed abolito dal Concilio di Trento, a metà del ‘500. Ma in terra sarda pare sia rimasto, come rito, fin dopo la Seconda guerra mondiale. A confermarlo sono le ultime testimonianze che documentano fatti accaduti a Luras, nel 1929, e ad Orgosolo, nel 1952.
Santona, medico dei malati o stregona si è da sempre trattato di una figura inquietante, protetta dalla complicità delle comunità con un compito che, a primo acchito, poteva sembrare macabro, ma che in realtà era spinto da stimoli di pietà e carità.
Quasi un atto di misericordia nei confronti del moribondo, un ultimo passo necessario contro l’estrema sofferenza, ma anche un aiuto a favore delle famiglie stesse.
Generalmente, si trattava di classi sociali poco abbienti, che vivevano in zone di campagna lontane giorni di cavallo da un posto medico, e dove i malati erano abbandonati alla sorte.
Ma sa femina accabadora interveniva anche per medicare piaghe particolarmente infette, mettere punti di sutura alle ferite, lenire sofferenti scottature, e anche come levatrice nell’assistere la puerpera. Questo non deve sorprendere visto che, già un tempo, la nascita e la morte erano considerate un anello congiunto del ciclo stesso della vita.
Diciamo, quindi, che questa dama faceva il possibile per aiutare le famiglie anche se il suo vero ruolo era intervenire quando un malato era ormai terminale, senza speranza.
Essa, infatti, doveva mettere fine alle sofferenze. Doveva cacciare l’anima, il soffio vitale, da quei corpi doloranti e tormentati da estenuanti agonie.
Il suo rituale era preciso e scandito da un’austera solennità. La dama nera arrivava in casa della famiglia sempre di notte dove veniva accompagnata nella stanza del sofferente.
Quando la porta si spalancava, il moribondo, sdraiato sopra il suo letto d’angoscia, vedendola con il suo vestito nero e con gli occhi coperti dal velo, capiva che la sua ora stava per scoccare.
Sa femina accabadora faceva uscire, da quella stessa stanza, tutti i familiari: non voleva alcun testimone per il timore di un giudizio divino.
Per prima cosa, liberava comò e pareti da santini, crocifissi, oggetti sacri e ricordi di famiglia. Poi toglieva al morente catenine, anelli o amuleti che portava con sé quale segno di speranza. Una depurazione necessaria per evitare impedimenti alla “partenza”. Non si poteva rischiare che ricordi e preghiere, dei suoi cari in vita e di quelli estinti, lo proteggessero prolungando così il suo distacco terreno.
E anche l’estremo gesto della sacerdotessa di morte era scandito da azioni studiate:
dal suo sacchetto nero di lana grezza, prendeva una specie di martelletto di legno d’ulivo (denominato “su mazzolu”) con il quale batteva lo sventurato, con un colpo secco e deciso, nell’area delle tempie o sulla fronte. E se, il moribondo non riusciva a lasciarsi morire in pace, la sacerdotessa di morte usava anche un cuscino oppure si attaccava al suo collo. Quest’ultimo era un rituale macabramente legato alla nascita: sa femina accabadora stringeva il collo del morituro tra le sue cosce e lo soffocava proprio lì dove il nascituro trova la luce.
Infine, dopo aver reso l’anima al cielo, la dama nera usciva in punta di piedi senza chiedere o ricevere compensi. Infatti, era considerato peccato ed era antietico ai precetti della superstizione venir pagati per far morire, diverso per far guarire.
I familiari del malato, però, per esprimere gratitudine e ringraziamento per il servizio reso offrivano comunque frutti della terra, ma questo aveva un suo perché: in pratica avere un malato in casa, in epoca di pastorizia e coltivazione dei terreni, significava perdere forze e risorse di lavoro, assolutamente preziose per l’economia e la sussistenza della famiglia stessa. Per questo ricevere frutti della terra, come ringraziamento, era quasi un onore. Per questo sa femina accabadora era riconosciuta e rispettata nel paese, perché accettava solo ciò che la tradizione permetteva. Proprio perché il procurare la morte ad una persona in agonia, non era bestialità o barbarie, ma atto di misericordia a favore della famiglia stessa.
Difficile dire se quella della dama nera sia verità storica o mito legato alla tradizione sarda. Certo è, però, che esistono testimonianze di uomini e donne oltre a memorie scritte, così come detti ed aforismi popolari che lasciano intendere ad un fenomeno esistito. Tanto è vero che, ancora oggi, esiste un’ingiuria pronunciata in sardo, che recita: “Sa e s’acabadora ti dian” che è un triste auspicio per una morte lenta e penosa, tanto da essere risolta solo con l’ingerenza di sa femina accabadora. MG
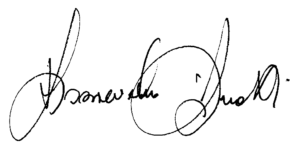
Riproduzione riservata
FOTO MUSEO ETNOGRAFICO GALLURAS:
“Il Museo della Femina Agabbadòra “